
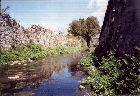
La Vecchia Dorgia

Vecchi autobus

Via Palmaria (monte)
Sprofondato
nella sua logora poltrona, Filippo sospirò profondamente, con il
foglio tra le mani e lo sguardo perso nel vuoto, poi inforcò
nuovamente gli occhiali da presbite e si decise a rileggere quelle
righe per la quinta volta.
“Che
quartiere è il Canaletto?
Un quartiere che non puoi rappresentare con un’immagine, con un
luogo delimitato e uguale per tutti, come una piazza o una chiesa.
Un quartiere che, in molti angoli, è sconosciuto persino ai suoi
abitanti. Che ha un fascino poliedrico e sfuggente, percepibile solo
se cammini per le sue strade, tutte le sue strade, con la curiosità
avida di un turista. Vivrai momenti in cui ti conquisterà, altri in
cui ti sembrerà odioso.
Perché il Canaletto è il quartiere di Via Carducci e di Via San
Bartolomeo, le due strade che lo attraversano longitudinalmente,
piene di traffico, rumore e smog. Di grigio che ti opprime e di
polvere che ti soffoca.
Ma è anche il quartiere delle piccole e graziose vie trasversali,
che scendono da monte a mare, protese verso il golfo, delle cui
isole alcune portano il nome, dove trovi vecchie baracche di legno
scuro e case diroccate disabitate da anni, dove trovi antichi orti,
cani che ti guardano da dietro i cancelli e non abbaiano, forse per
non turbare la quiete che ti fa sembrare di essere in campagna, e
invece sei a soli pochi metri dall’inferno di Via Carducci. Dove,
quando passi, la gente ti osserva incuriosita e sospettosa, perché
sei una faccia nuova, uno che cerca qualcosa e non sanno cosa. Non
immaginano che sei lì solo per trovare sensazioni, frugando gli
orti con lo sguardo e annusando l’aria che la domenica mattina sa
di ragù e di arrosto. Ed in quegli orti ci sono fiori, insalata, ma
anche, a sorpresa, barche capovolte che attendono l’estate, a
ricordarti che sei in un quartiere di mare. Anzi, di più: un
quartiere germogliato su una terra dove un tempo c’era il mare,
che arrivava fino a Migliarina. Ed il mare lo intuisci, perché lo
sguardo, al di là dei platani di Viale San Bartolomeo, non trova né
monti, né palazzi; lo senti nell’aria, o addirittura lo vedi, dai
piani alti delle case, vicino e splendente, ma oggi beffardamente
intoccabile.
Un quartiere dove c’è “La Marina”, uno spettacolo di
tradizioni e di amore per il mare, con i pontili, le baracche, le
barche, l’odore di pesce, di muscoli e di gatti. Un microcosmo
creato tanti anni fa dai muscolai, molti immigrati da Taranto, che lì
impiantarono i vivai e le strutture per curarli. Un mondo cancellato
e ricostruito, cinquanta metri più in là, per rubare al mare
spazio da cedere alle attività di un porto sempre più invadente.
E, tra poco, ucciso per sempre da Spezzini affamati e cannibali.
Ma è anche un quartiere di acqua dolce, con i mille canali che lo
solcano: quelli puliti, come la Nuova Dorgia, sopravissuta alla
mania che avevano un tempo di coprire tutti i torrenti; la Vecchia
Dorgia, con i suoi trenta metri di inaspettata limpidezza, che ti
sorprendono se percorri Via del Tino. E, all’estremità opposta,
il Cappelletto, liberato dai grossi tubi in passato utilizzati dalla
raffineria dismessa. Poi, quelli più sporchi, umiliati dalla puzza,
come il fosso Rossano, che, quando ero ragazzo, divideva Via Tazzoli
da una zona su cui sorgevano oscuri capannoni di attività
artigianali. Adesso il Rossano è coperto, c’è il tribunale, c’è
un grande supermercato: gli sono rimasti cinque metri, a fianco
della nuova sede della Pubblica Assistenza, per affacciarsi al mondo
e dire che c’è ancora, proprio lì dove in tempi remoti lavorava
addirittura un mulino. E ci sono altri rigagnoli, nascosti e
anonimi, di acque a volte poco pulite che emergono e scompaiono in
pochi metri. E poi, le fontane, dove una volta l’acqua scorreva
incessantemente: quelle di Via Giulio Della Torre e di Via della
Pianta, ancora funzionanti, e quella di Viale San Bartolomeo,
all’incrocio con Via Palmaria, con tanto di vaschetta, ma
purtroppo chiusa e ridotta ad un ricettacolo di immondizia.
E’ il quartiere dove c’è il deposito dell’ATC, o FITRAM, come
si chiamava quando gli autobus erano dipinti di verde scuro. La tana
dove la sera i filobus rientrano silenziosi, vuoti di persone, ma
pieni di pensieri, parole, gioie, dolori che la gente ha lasciato
tra quei sedili in un giorno di vita che è passato come tanti. La
tana dalla quale, all’alba, escono lentamente con i fari accesi,
per andare a raccogliere persone infreddolite che aspettano
l’apparizione di quel grosso muso rassicurante. In quell’angolo
del Canaletto, tutti i giorni, da cinquant’anni, il rumore secco
dello scambio di Via Giulio Della Torre, battuto dall’autista,
sovrasta per un istante il sibilo discreto del motore elettrico. Ma
sotto ai capannoni del deposito ci sono anche i vecchi bus di quella
meraviglia che è il Museo dei Trasporti, alcuni riportati
all’antico splendore, altri, nel piazzale desolato al di là di
Via Carducci, arrugginiti e cadenti, che guardano da anni il loro
deserto dei Tartari di asfalto vuoto, sperando in un restauro e,
soprattutto, in una sede che li riporti alla gente.
Ma è anche il quartiere dei rioni squadrati, nati frettolosamente
negli anni cinquanta su due metri di terra di riporto, con i palazzi
anonimi, bruttini, ma con i portici di Corso Nazionale, che vanno
dagli imponenti palazzi di Viale San Bartolomeo al verde ordinato
della Maggiolina; quei portici dove in inverno puoi passeggiare
riparato dalla pioggia ed in estate godere di una brezza sana e
fresca che viene dal mare; quei portici con quelle colonne alte che
i cani non mancano di annusare e tra le quali da bambini giocavamo a
nascondino.
E, per i nonni, è il quartiere dei campi coltivati, quei campi che
attraversavo tutte le mattine con gli amici per andare a scuola, al
Fontana, arrivando spesso in classe con le scarpe infangate.
Passavamo tra le vecchie case dei contadini, sulle assi di legno che
superavano piccoli canali, tra i cani che scodinzolavano
amichevolmente nell’aia: qualche traccia di quel mondo rurale
resiste ancora oggi.
Il Canaletto è anche il quartiere con due cinema, uno dei quali, il
Garibaldi, coraggiosamente riaperto dopo anni di inattività ed alla
sua seconda resurrezione, dopo quella del ’46 che seguì il
bombardamento subito tre anni prima. Ed al Canaletto c’è una
biblioteca virtuale tra le prime sorte in Europa, ci sono palazzi
nuovi, moderni, parchi eleganti, puliti e funzionali come la
Maggiolina, talvolta costruiti laddove c’erano piste da ballo o
piazzali vuoti e polverosi, dove noi ragazzini ci inventavamo
giochi, improvvisando piste per biciclette con vecchi oggetti
abbandonati o rincorse e nascondini tra autotreni parcheggiati, e
dove a Natale, finalmente, arrivava il Luna Park, con le sue luci
colorate, i suoi suoni ripetitivi, l’odore di zucchero filato,
attirando facce nuove da tutta la città: perché per molti Spezzini
quello era l’unico motivo per venire al Canaletto.
Ma il Canaletto è anche il quartiere, forse l’unico, che non ha
una piazza, un monumento o una chiesa in cui identificarlo. O
meglio, la chiesa, ovviamente, ce l’ha, ma non è quella di una
volta. Il suo campanile moderno, che si vede anche da in mezzo al
mare, è un faro ingannatore, perché lì c’è la chiesa, ma non
il cuore del quartiere, come invece ti aspetteresti. Quello è nella
zona di Via Saffi e Via Della Torre, dove, fino a vent’anni fa, si
fermava il carretto del pescivendolo, e vicino a dove, fino al 1969,
sorgeva la vecchia chiesetta, in Corso Nazionale, qualche metro
sotto il livello stradale. Da allora per raggiungere la chiesa
bisogna passare dall’inferno di Via Carducci: una barriera
psicologica (e non solo) dissuasiva come un campo minato, che tutti
i ragazzi del quartiere hanno superato centinaia di volte per
trascorrere pomeriggi all’oratorio, a giocare a pallone.
Insomma, un quartiere dai mille volti, senza una precisa identità,
pieno di contraddizioni. Forse, proprio come la città cui
appartiene. Che amiamo e che ci fa arrabbiare, la nostra splendida
Spezia.”
Tolse
gli occhiali, posò il foglio sul tavolino e guardò sconsolato la
tela sul cavalletto, ancora perfettamente bianca. Una verginità che
durava da due giorni e che iniziava a farlo innervosire. Già in
altre occasioni gli era stato chiesto di realizzare un dipinto che
rappresentasse una città, un paese, un quartiere. Se l’era sempre
cavata con delle oneste opere figurative, una sorta di fotografie un
po’ personalizzate per le quali aveva poi ricevuto complimenti (a
volte un po’ eccessivi) e ringraziamenti da parte di cittadini ed
autorità. Per il Canaletto era diverso, e quelle parole scritte di
getto dal suo più giovane amico Roberto tardavano ad accendere in
lui la luce magica dell’ispirazione, anzi quasi lo confondevano.
Brontolando qualcosa, si decise a vincere la sua innata pigrizia:
prima di uscire si mise il foglio in tasca, piegandolo con la cura
che un avventuriero avrebbe riservato alla mappa del tesoro. Poi andò,
armato di una curiosità che, più forte della sua stanchezza, gli
avrebbe fatto percorrere ogni metro di quel quartiere a lui pressoché
sconosciuto.
La sera, cullato dal filobus che lo stava riportando a casa, si
convinse che, prima dell’alba, il quadro avrebbe preso forma;
forse non sarebbe piaciuto a chi vi avesse cercato i soggetti usati,
ma era sicuro che Roberto, e tutti coloro che amavano il Canaletto,
lo avrebbero ringraziato per avere saputo fissare sulla sua tela le
centomila sensazioni di quello strano quartiere.